|
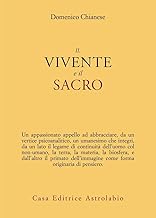 Ogni uomo alberga in sé qualcosa di sacro. La verità e la bellezza sono sacre: sacro nella scienza è la verità, sacro nell?arte è la bellezza. Sacra è la cura dei pazienti e la cura della vita, e la cura per la vita significa prendersi cura del vivente, cura di un oggetto che ha la qualità di essere vivo. Partendo da questa premessa, che è anche un approdo, la ricerca dell?autore si muove liberamente tra estetica, epistemologia, antropologia, storia delle religioni, filosofia della fisica, storia delle idee (oltre che, naturalmente, psicoanalisi) alla ricerca dei principi fondatori di quella che potremmo chiamare una ?antropologia dell?immagine?, una scienza umana in cui l?immagine è il dato primario e al tempo stesso il dato ultimo, un costrutto irriducibile ad altri costrutti, siano essi (neuro)psicologici, fisiologici o verbali; l?immagine è ciò che consente una mediazione diretta, non solo tra uomo e natura, ma anche tra uomo e uomo, e tra uomo e cultura; l?immagine, infine, è interamente nel dominio del sensibile; prende corpo, nella sua specificità, attraverso i sensi. Quale impatto un?ottica di questo genere può avere sul modo di pensare e di praticare la conoscenza, e in particolare sul modo di intendere e praticare la psicoanalisi? Nella trattazione dell?autore, questa domanda trova una risposta implicita, perché, coerentemente col suo vertice preferenziale, egli sceglie di affidare la sua riflessione esclusivamente a una dialettica dell?immagine, ossia all?elaborazione di un sogno che viene narrato subito, all?apertura del libro. Chi lo ha sognato? È vero o inventato? o forse costruito da più sogni? e in tal caso, di chi? Non si sa, perché l?importante non è l?autore del sogno (se ce n?è uno) ma l?elaborazione delle sue immagini, che finisce per costituire l?ossatura di questo singolare contributo all?umana impresa. |

