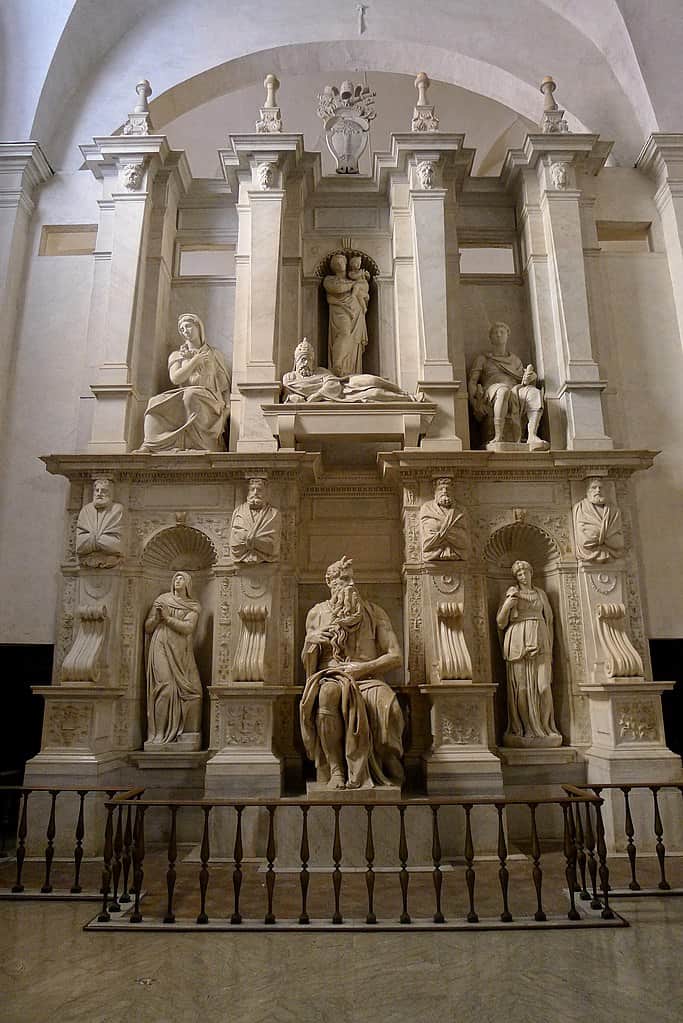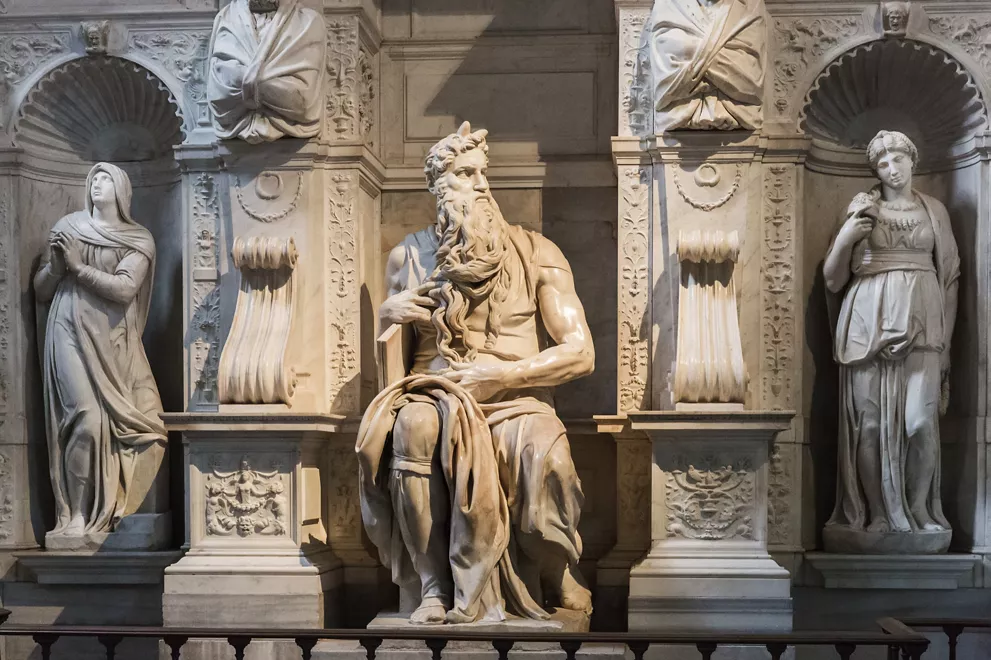91
Pensieri, riflessioni, saggi / Aporofobia
« Ultimo post da Doxa il Febbraio 29, 2024, 15:43:21 »Aporofobia: parola composta di origine greca, formata da “àporos” (= povero) e dal suffisso “- fobos” (= paura): paura del povero o avversione verso il povero. Il neologismo è stato coniato dalla filosofa spagnola Adela Cortina Orts, che ha recentemente pubblicato il libro titolato: “Aporofobia. Il disprezzo dei poveri” (edit. Timeo), recensito lo scorso 25 febbraio sull’inserto “Domenica” del quotidiano “Il Sole 24 Ore” dal prof. Vittorio Pelligra, docente di politica economica all’Università di Cagliari.
Pelligra nel suo articolo evidenzia che durante i primi mesi dell’invasione russa in Ucraina, l’esodo provocato dalla guerra ha generato anche in Italia un fenomeno paradossale: la tradizionale ostilità nei confronti degli immigrati da parte delle forze politiche di destra si è trasformata in disponibilità, solidarietà e accoglienza. Questo atteggiamento ha contribuito ad incrementare la “guerra fra poveri” con esponenti politici che distinguevano tra “profughi veri”, quelli provenienti dall’Ucraina e “profughi finti”, quelli provenienti dall’Africa, Medio Oriente o dall’Asia centrale. Cosa c’è alla base di questo trattamento differenziato ?
La Orts, docente di etica e filosofia politica nell’Università di Valencia, nel suo libro dice che la chiave interpretativa corretta è quella economica: il pil pro-capite dell’Ucraina si avvicina ai cinquemila dollari, mentre quello del Sudan, per esempio, è inferiore ai 600 dollari.
Gli stranieri non ci piacciono, ma quelli poveri ci piacciono ancora meno. E’ l’aporofobia, il rifiuto, l’avversione e il disprezzo per i poveri. E’ vero ? Per quanto mi riguarda non disprezzo i poveri ma i finti poveri, come quei “nomadi” che chiedono l’elemosina ed hanno il reddito d’inclusione perché nati in Italia ma nel contempo dalla Romania e da altri luoghi fanno venire in Italia persone menomate per impietosire i passanti. Molti di loro come “professione” si dedicano all’accattonaggio. Tale “mestiere” se lo stanno imparando anche gli africani. Chiedono l’elemosina davanti l’entrata dei supermercati, dei centri commerciali ma anche dei negozi di alimentari. Li vedo sia a Roma sia a Milano, dove vado spesso.
Torno all’articolo di Pelligra: “Come la xenofobia, anche l’aporofobia è una forma di odio sociale, indistinto. Non riguarda questa o quella persona conosciuta, ma questa o quella categoria di persone sconosciute: gli stranieri, quelli che hanno la pelle di colore diverso, o i poveri e i miserabili. Infatti quando i ricchi pensionati inglesi o italiani si trasferiscono in Spagna o Portogallo o gli infermieri spagnoli e le badanti bielorusse vanno a lavorare in Gran Bretagna o vengono qui da noi, nessuno ha da obiettare.
Il problema non è lo straniero ma il suo conto in banca. (Non sono d’accordo con Pelligra). Questo atteggiamento è in palese contrasto con l’etica scritta e pensata che ratifichiamo in pompa magna nelle dichiarazioni e nei trattati internazionali. Infatti la lotta alla xenofobia, al razzismo, all’omofobia”.
La filosofa Orts: “nei nostri Paesi democratici che si dichiarano a favore dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti gli esseri umani (…) è ormai un compito che spetta alla giurisprudenza e alle forze dell’ordine, ed è un compito arduo. Il fatto che alla base anche della xenofobia ci sia il disprezzo per i poveri non può in nessun modo farci star meglio perché, come dice l’autrice, ‘aporofobici lo siamo quasi tutti’. L’aporofobia, come la xenofobia, ha basi biologiche. Nasce dalla naturale diffidenza per il diverso”.
Il prof. Pelligra rileva che durante la preistoria le piccole comunità di cacciatori-raccoglitori impararono che per sopravvivere era importante il reciproco altruismo, la cooperazione per avere le risorse necessarie alla vita e organizzare la difesa contro i nemici. La reciprocità, il dare e avere è il collante della cooperazione, della sopravvivenza e dello sviluppo. E chi non può dare ? Chi è impossibilitato a contribuire ? Questi sono gli “esclusi”, i poveri. L’aporofobo non ha nulla da dare e tutto da prendere, uno con cui non vogliamo avere nulla a che fare. Se poi tale posizione viene rinforzata come capita spesso da discorsi d’odio, o dalla retorica meritocratica le conseguenze sono più gravi: il povero va allontanato e combattuto, perché la sua povertà è la sua colpa. Lo straniero non va bene , neanche il povero. E il disabile ? Anche i disabili, soprattutto quelli gravi, hanno tutto da prendere e nulla da dare. Allora nel migliore dei casi il rapporto con gli esclusi non riguarda la giustizia ma la benevolenza. Non è difficile rinvenire in questa impostazione la causa alla base della rottura dei patti intergenerazionali in fatto di pensioni, delle resistenze verso le società multietniche, la crisi delle politiche pubbliche negli ambiti dell’istruzione, della sanità e del welfare e più in generale di tutte le politiche di contrasto alla povertà e di promozione delle pari opportunità. La cura ? Ci vuole l’altruismo, il desiderio di cura verso chi ha bisogno, promuovere la pari dignità delle persone, capaci di tirar fuori la parte migliore di ogni essere umano”.
segue
Pelligra nel suo articolo evidenzia che durante i primi mesi dell’invasione russa in Ucraina, l’esodo provocato dalla guerra ha generato anche in Italia un fenomeno paradossale: la tradizionale ostilità nei confronti degli immigrati da parte delle forze politiche di destra si è trasformata in disponibilità, solidarietà e accoglienza. Questo atteggiamento ha contribuito ad incrementare la “guerra fra poveri” con esponenti politici che distinguevano tra “profughi veri”, quelli provenienti dall’Ucraina e “profughi finti”, quelli provenienti dall’Africa, Medio Oriente o dall’Asia centrale. Cosa c’è alla base di questo trattamento differenziato ?
La Orts, docente di etica e filosofia politica nell’Università di Valencia, nel suo libro dice che la chiave interpretativa corretta è quella economica: il pil pro-capite dell’Ucraina si avvicina ai cinquemila dollari, mentre quello del Sudan, per esempio, è inferiore ai 600 dollari.
Gli stranieri non ci piacciono, ma quelli poveri ci piacciono ancora meno. E’ l’aporofobia, il rifiuto, l’avversione e il disprezzo per i poveri. E’ vero ? Per quanto mi riguarda non disprezzo i poveri ma i finti poveri, come quei “nomadi” che chiedono l’elemosina ed hanno il reddito d’inclusione perché nati in Italia ma nel contempo dalla Romania e da altri luoghi fanno venire in Italia persone menomate per impietosire i passanti. Molti di loro come “professione” si dedicano all’accattonaggio. Tale “mestiere” se lo stanno imparando anche gli africani. Chiedono l’elemosina davanti l’entrata dei supermercati, dei centri commerciali ma anche dei negozi di alimentari. Li vedo sia a Roma sia a Milano, dove vado spesso.
Torno all’articolo di Pelligra: “Come la xenofobia, anche l’aporofobia è una forma di odio sociale, indistinto. Non riguarda questa o quella persona conosciuta, ma questa o quella categoria di persone sconosciute: gli stranieri, quelli che hanno la pelle di colore diverso, o i poveri e i miserabili. Infatti quando i ricchi pensionati inglesi o italiani si trasferiscono in Spagna o Portogallo o gli infermieri spagnoli e le badanti bielorusse vanno a lavorare in Gran Bretagna o vengono qui da noi, nessuno ha da obiettare.
Il problema non è lo straniero ma il suo conto in banca. (Non sono d’accordo con Pelligra). Questo atteggiamento è in palese contrasto con l’etica scritta e pensata che ratifichiamo in pompa magna nelle dichiarazioni e nei trattati internazionali. Infatti la lotta alla xenofobia, al razzismo, all’omofobia”.
La filosofa Orts: “nei nostri Paesi democratici che si dichiarano a favore dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti gli esseri umani (…) è ormai un compito che spetta alla giurisprudenza e alle forze dell’ordine, ed è un compito arduo. Il fatto che alla base anche della xenofobia ci sia il disprezzo per i poveri non può in nessun modo farci star meglio perché, come dice l’autrice, ‘aporofobici lo siamo quasi tutti’. L’aporofobia, come la xenofobia, ha basi biologiche. Nasce dalla naturale diffidenza per il diverso”.
Il prof. Pelligra rileva che durante la preistoria le piccole comunità di cacciatori-raccoglitori impararono che per sopravvivere era importante il reciproco altruismo, la cooperazione per avere le risorse necessarie alla vita e organizzare la difesa contro i nemici. La reciprocità, il dare e avere è il collante della cooperazione, della sopravvivenza e dello sviluppo. E chi non può dare ? Chi è impossibilitato a contribuire ? Questi sono gli “esclusi”, i poveri. L’aporofobo non ha nulla da dare e tutto da prendere, uno con cui non vogliamo avere nulla a che fare. Se poi tale posizione viene rinforzata come capita spesso da discorsi d’odio, o dalla retorica meritocratica le conseguenze sono più gravi: il povero va allontanato e combattuto, perché la sua povertà è la sua colpa. Lo straniero non va bene , neanche il povero. E il disabile ? Anche i disabili, soprattutto quelli gravi, hanno tutto da prendere e nulla da dare. Allora nel migliore dei casi il rapporto con gli esclusi non riguarda la giustizia ma la benevolenza. Non è difficile rinvenire in questa impostazione la causa alla base della rottura dei patti intergenerazionali in fatto di pensioni, delle resistenze verso le società multietniche, la crisi delle politiche pubbliche negli ambiti dell’istruzione, della sanità e del welfare e più in generale di tutte le politiche di contrasto alla povertà e di promozione delle pari opportunità. La cura ? Ci vuole l’altruismo, il desiderio di cura verso chi ha bisogno, promuovere la pari dignità delle persone, capaci di tirar fuori la parte migliore di ogni essere umano”.
segue


 Post recenti
Post recenti